JAZZ
BILLIE HOLIDAY
|
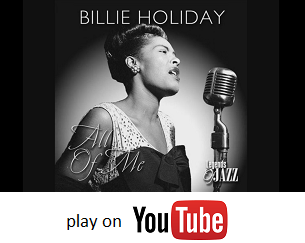 |
 |
Eleanora Fagan. Nata a Baltimora il 7 Aprile 1915. Un nome e una data che non dicono nulla. E se qualcuno, per giunta, vedendola davanti al fonografo di quella casa di tolleranza di Harlem, New York, dove era finita minorenne per sfidare la fame e dove ogni tanto aveva il permesso di ascoltare i “padelloni”di Louis Armstrong o di Bessie Smith, le avesse sussurrato all’orecchio che da povera ragazza di colore e senza mezzi (nata da una relazione tra due minorenni, affidata a tutori e riformatori) sarebbe diventata regina del jazz di tutti i tempi, lei per prima non ci avrebbe scommesso un quarto di dollaro. Eppure ognuno ha il suo e quello della figlia di Sadie Fagan - ballerina e domestica - e di Clarence Holiday, ottimo suonatore di banjo, sarà un destino immenso, pur lasciandole in dote una specie di maledizione che la vedrà divisa tra le glorie più alte e le più basse discese nel fango. Billie Holiday, questo il nome che tutti conosciamo, è la prima vera “donna-jazz”, colei che passa alla storia non solo per aver scalato tutte le classifiche di vendita nei primi anni dell’industria discografica americana, ma soprattutto per aver “reinventato” del jazz canto e fraseggio con una vocalità che per la prima volta si scopre “strumento complice” e di così grande importanza da poter addirittura “gareggiare” con l’orchestra, mettendo in secondo piano i suoi stessi comprimari attraverso l’uso sapiente di ritmo, di controcanto, di improvvisazione che tuttavia mai si perdono in egoistici assoli fondendosi invece con grande naturalezza nella complicità dell’interplay.
Imitata fino allo sfinimento per oltre sessant’anni da icone musicali piccole e grandi - da Nina Simone a Cassandra Wilson - studiata, analizzata nella sua tecnica vocale, “Lady Day,”che in quest’anno volgente al termine avrebbe compiuto cento anni, la “Lady with the blue note” (leggendaria la sua gardenia bianca tra i capelli) costretta pur negli anni di maggior successo ad utilizzare le entrate di servizio di teatri e locali perché nera, resta un mistero finanche a se stessa. Complice una capacità del tutto innata, direi prenatale, e non avendo mai preso una sola lezione di musica, la Holiday faceva di tutto il suo jazz un “blues” che non era mai definitivamente blues, riuscendo inoltre ad accattivare il suo pubblico per quella strana mancanza di senso gospel nelle vene che a differenza di tutti i cantanti di colore la rendeva così nuova, inusuale e per ciò stesso amata. Quella voce fumosa e quella tendenza al trasalimento e al “volo” nelle sue ottave, pur non arrivando mai alle estensioni di una Ella Fitzgerald, furono fin dal primo momento gli elementi di un autentico “miracolo da palcoscenico” che innervava di malinconia e sofferenza, di pathos e non di patetismo ogni esibizione. Su tutto, un evidente amore per lo “storytelling” (una sorta di dialogo cantato) diventava ulteriore punto focale della sua tecnica, tanto che, come un Rimbaud in poesia, la cantante pareva rendere nuova ogni parola da lei pronunciata, fosse anche la più banale (e i testi di molti standard jazz in effetti banali lo sono per davvero) instaurando di volta in volta un rapporto intimo ed esclusivo con l’orecchio di ogni ascoltatore. Questa voce duttile, attoriale, capace di scivolare con la dovuta classe anche nello swing, questa forza che usciva fuori da una donna via via consumata da amori violenti e laceranti, da truffe finanziarie e dallo scotto pagato agli stravizi di una vita intera (morì di cirrosi epatica a soli quarantaquattro anni con settanta centesimi di conto in banca) non poteva non trovare in un pezzo come “Strange Fruit” l’epitome simbolica della sua carriera. Questo pezzo non propriamente jazz che chiuse fino alla fine tutti i suoi concerti ma che richiedeva esplicito permesso scritto per essere eseguito, mettendo in scena senza pudore la pratica non insolita del linciaggio degli afroamericani, apriva un netto spartiacque nel mondo dello spettacolo così come nella società, quasi a dire che il jazz ha sì il potere di intrattenere ma anche quello di denunciare. E quella situazione, inutile dirlo, Billie Holiday la sentiva e la viveva sulla pelle. Ma con la stessa intensità di come a mio avviso sentiva su di sé l’accattivante tempo in levare di una “Blue Moon”, di una “All of me” o le movenze trascinate di una straziante “You’ve changed” per molti suo testamento spirituale. Le differenze non erano molte. Perché tutto in lei restava “vissuto” Perché il potere della musica, il capriccio del jazz con le sue armonie irregolari almeno quanto la sua stessa vita, il jazz, con quell’irriducibile anelito alla libertà e alla novità di cui Billie Holiday era fortemente consapevole, aveva la capacità di oltrepassare di gran lunga le parole di denuncia di una “Strange Fruit” diventando esso stesso novità, genio, scardinamento, protesta. Billie Holiday passa alla storia anche per questo: è un ibrido di classe che si vanta di essere tale, una regina sanguemisto, insomma uno “strano frutto” ma in definitiva una vera stella, inafferrabile, inusuale e dallo splendore fortemente esplosivo ed abbagliante.

